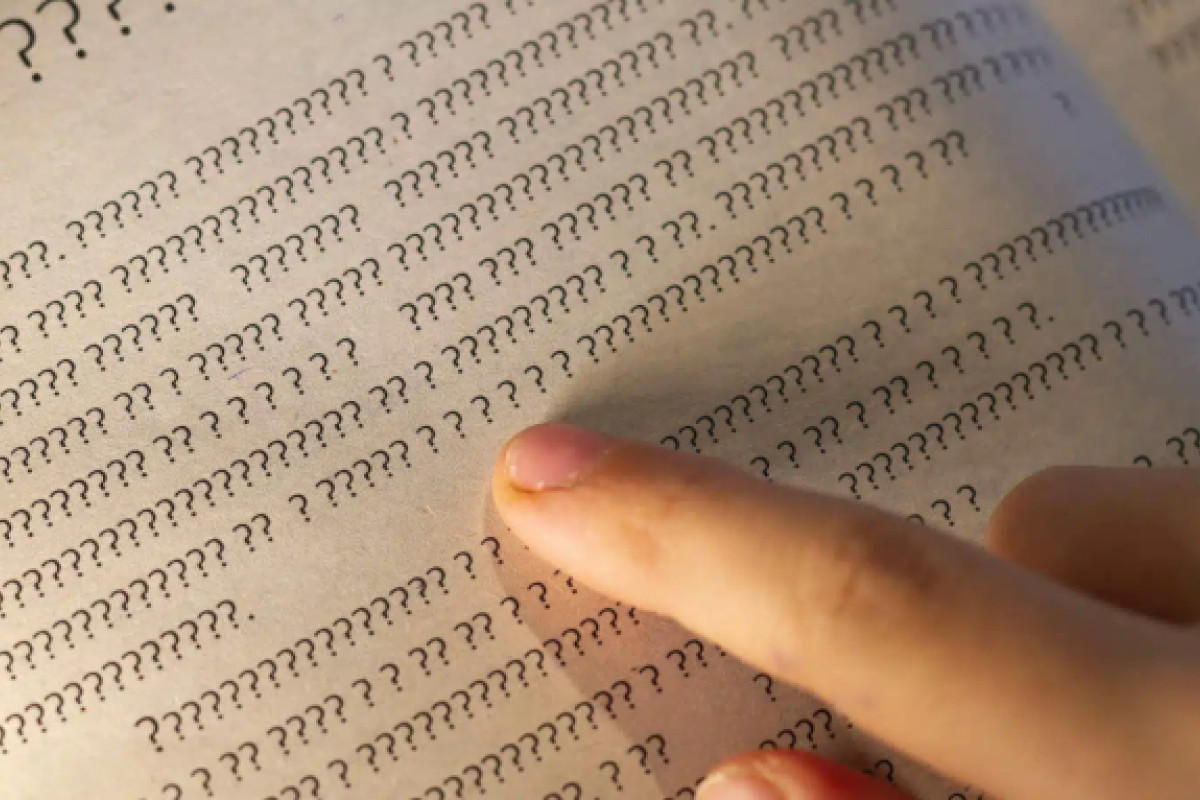L’analfabetismo funzionale è un problema che riguarda quasi un terzo degli italiani adulti, nonostante sia spesso ignorato. Non si tratta di chi non sa leggere o scrivere, ma di chi non riesce a comprendere testi, interpretare dati o risolvere situazioni pratiche. Questo dato emerge chiaramente dall’indagine OCSE-PIAAC del 2023, che mette in luce una grave difficoltà diffusa in molte aree del paese, con effetti diretti sulla società e sulla democrazia.
Analisi della diffusione e dei dati ocse
Secondo l’indagine condotta nel 2023 dall’OCSE su adulti tra i 16 e i 65 anni, più del 35% degli italiani mostra competenze molto basse in literacy e numeracy. Questo significa che queste persone riescono a leggere un testo ma non a capirlo davvero o a usarlo nella vita di tutti i giorni. Nel problem solving, ossia la capacità di affrontare situazioni nuove, la percentuale peggiora ancora: il 46% si colloca ai livelli più bassi, contro il 29% della media europea.
Queste cifre sono allarmanti e mostrano un’Italia divisa. Mentre Nord e Centro si avvicinano alla media europea, con regioni come il Nord-Est e la Toscana che mostrano risultati discreti, il Sud e le isole presentano valori drammaticamente più bassi. In alcune zone meridionali, meno di un adulto su cinque raggiunge livelli accettabili di competenze linguistiche e matematiche.
La differenza emerge anche per fasce di età. I giovani registrano risultati migliori rispetto agli adulti più anziani, ma senza eccellere. La situazione peggiora tra i 55 e i 65 anni, spesso legata a basso livello di istruzione o a mancanza di formazione continua. Si registra anche il fenomeno dell’analfabetismo di ritorno, ovvero la perdita di competenze acquisite, che riguarda circa il 30% della popolazione fra 25 e 65 anni.
Divario territoriale e generazionale nelle competenze di base
Il gap tra Nord e Sud del paese è evidente nelle statistiche sulle competenze di base. Le regioni del Nord-Est e la Toscana si avvicinano agli standard europei, mentre Sicilia, Calabria e Sardegna segnano punteggi molto bassi. Lo svantaggio territoriale si riflette anche nell’accesso a opportunità formative e culturali, condizioni decisive per mantenere e sviluppare le competenze.
A livello generazionale, i più giovani mostrano qualche margine di miglioramento rispetto alle fasce adulte. Ma i livelli di eccellenza restano limitati: solo il 5% degli italiani raggiunge i livelli più alti nelle prove di literacy, numeracy e problem solving, metà della media OCSE. Il dato è significativo anche perché indica una fragilità strutturale, che influisce sulla competitività e sulla capacità di affrontare le sfide del mondo moderno.
L’analfabetismo di ritorno gioca un ruolo importante nel peggioramento delle competenze negli adulti più anziani. Senza un esercizio costante o occasioni di aggiornamento, anche chi ha frequentato regolarmente la scuola può perdere capacità fondamentali. Questo fenomeno interessa soprattutto la fascia tra i 25 e i 65 anni.
Conseguenze sociali e politiche dell’analfabetismo funzionale
Questa diffusa mancanza di competenze comporta conseguenze rilevanti per la società italiana. In un contesto dove molti non riescono a leggere correttamente un documento o a interpretare un’informazione, aumenta il rischio che si diffonda disinformazione. Il fenomeno favorisce la delega a leader carismatici senza un reale confronto con i fatti o con la legge.
L’incapacità di interpretare testi e norme favorisce atteggiamenti di scarsa partecipazione politica informata. In pratica, cresce il terreno per approcci autoritari o populisti, perché la fragilità culturale fa perdere la capacità di mettere in discussione informazioni e decisioni. Questa dinamica condiziona il funzionamento della democrazia, che richiede cittadini in grado di comprendere e valutare le questioni pubbliche.
La mancanza di competenze incide, inoltre, su aspetti pratici della vita quotidiana: dalla gestione delle finanze personali alla comprensione di servizi pubblici o indicazioni sanitarie. È un problema che tocca diversi livelli, dal sociale al politico, compromettendo in modo sostanziale le forme di partecipazione.
Sfida educativa e culturale in italia
L’Italia ha superato l’analfabetismo del passato in termini formali, ma si trova ad affrontare la sfida dell’analfabetismo funzionale. La questione non riguarda solo la scuola, ma il contesto più ampio della formazione continua e dell’accesso alle risorse culturali. Investire sulla riqualificazione degli adulti e promuovere la cultura come mezzo per rafforzare la cittadinanza dovrebbe diventare una priorità.
La debolezza nelle competenze di base sottolinea un nodo cruciale: la formazione non deve fermarsi all’anno scolastico, e l’educazione si rivolge a chiunque debba mantenere o recuperare capacità necessarie per comprendere il quotidiano. Una risposta efficace richiede risorse, politiche mirate e una nuova attenzione al valore sociale della cultura.
Il dato sulla piccola percentuale di eccellenza mette in luce quanto l’Italia debba lavorare per non rimanere indietro. La competenza diffusa è un presupposto per una società più efficace e una democrazia più solida. Non a caso, la scarsa preparazione rende difficile affrontare sfide come la digitalizzazione, la gestione delle informazioni o problemi complessi.
Il fenomeno resta spesso invisibile, ma blocca il cammino di crescita civile del Paese. La situazione esige un’azione decisa, capace di dare centralità alla cultura come strumento di emancipazione e partecipazione responsabile.